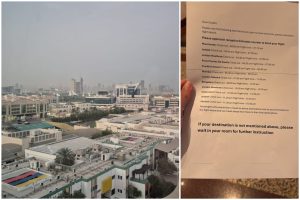Scrivere di Black Panther, dopo il suo clamoroso trionfo al box office americano e dopo i fiumi di inchiostro digitale, sprecati oltreoceano, per raccontarne l’importanza politica e culturale, è diventato piuttosto complesso.
Il valore puramente cinematografico del lavoro diretto da Ryan Coogler passa inevitabilmente in secondo piano, di fronte ad un fenomeno, che ha assunto proporzioni più marcatamente sociologiche, nel discorso pubblico americano.
Mai come in questi anni post-Obama, gli Stati Uniti e, di riflesso, la loro industria culturale e il loro cinema mainstream, ci sono parsi così incomprensibili e inessenziali.
Black Panther sembra essere il manifesto di questa confusione, un atto di militanza per il movimento Black Lives Matter e per la causa africana, declinato secondo il vocabolario limitato della Marvel: un film modestissimo, pedante, mal girato, fiacco, senza una sola idea di messa in scena e con un cast infinito di attori di colore, così presi da sè stessi e dalla seriosità loro ‘missione‘, da risultare involontariamente comici e da lasciar emergere invece i due unici bianchi comprimari, Martin Freeman e Andy Serkis.

Il film si apre con un prologo fantapolitico: la caduta di un meteorite in piena Africa Subsahariana, porta con sè un materiale dalle applicazioni infinite, il vibranium.
Grazie alle sue radiazioni, termina la lotta tra le cinque tribù che se lo contendono e nasce il regno di Wakanda, una sorta di metropoli ultramoderna, nascosta al mondo, che non deve sospettarne l’esistenza. Quattro tribù si uniscono sotto la guida di un capo, che prende il nome di Black Panther. La quinta si ritira sulle montagne.
Nel 1992 il re T’Chaka scopre che il fratello N’Jobu, innamoratosi di una ragazza californiana e preoccupato per lo stato degli afroamericani, sta contrabbandando il vibranium negli Stati Uniti. Per evitare che il mondo scopra la potenza del minerale, è costretto ad ucciderlo. Molti anni dopo, in occasione della sua morte, il figlio T’Challa sale al trono, ma deve affrontare un altro pericolo per la sicurezza di Wakanda. Il contrabbandiere Ulysses Klaue ha rubato un’arma wakandiana fatta di vibranium e vuole venderla al mercato nero in Corea del Sud.

L’acquirente è un uomo della CIA, Everett Ross. Black Panther/T’Challa, aiutato dalla sorella Shuri, dall’informatrice Nakia e da una coppia di guardie imperiali, riesce a catturare Klause e smascherare Ross. Rientrato a Wakanda, il protagonista però si accorge che il vero pericolo arriva da un uomo chiamato Erik Stevens, il figlio di N’Jobu.
Al netto di una trama d’origini piuttosto debole e telefonata, sia pure per una volta ambientata lontano dagli Stati Uniti, il film soffre di una clamorosa mancanza d’identità: non basta mettere in piedi la più sfrenata utopia africana, in cui è l’immaginaria Wakanda a farsi super-nazione, guida illuminata del mondo moderno.
I posticci sfondi digitali evitano quasi sempre di sfruttare la forza paesaggistica e luministica del continente africano, preferendo invece, prima una Corea metropolitana del tutto anonima, quindi una Wakanda spaziale, che non sa di nulla, mostrando tutta la miopia della sguardo di Coogler.

Peraltro pur ipotizzando una nazione africana avanzatissima, ricca, potente e tecnologicamente all’avanguardia da centinaia d’anni, grazie però ad una ‘manna’ letteralmente caduta dal cielo, Coogler ed il suo sceneggiatore Joe Robert Cole non rinunciano al solito clichè terzomondista, immaginando un consiglio tribale alla guida della città-stato, sfide rituali corpo a corpo per la conquista del trono, sul ciglio di una cascata, ed altre amenità coloniali da pieno Ottocento.
Nella seconda parte, il film deraglia completamente e come quasi tutti i Marvel si trasforma in una versione ripulita e digitale delle scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill.
In diciotto film nel corso degli ultimi dieci anni, quasi nessuno dei registi e produttori si è mai chiesto come riprendere e coreografare i combattimenti, come girare le lunghe sfide all’arma bianca, neppure copiando spudoratamente i capolavori asiatici, che sono, da almeno venticinque anni, parte dell’immaginario cinematografico collettivo.

Solo Scott Derrickson, in Doctor Strange, ha scelto di replicare spudoratamente Inception di Nolan, ed ha fatto benissimo.
Naturalmente i buoni vincono, i cattivi perdono e muoiono, non prima di essersi convertiti alla causa e i nostri eroi possono tornare nella Los Angeles di oggi ad occuparsi dei fratelli neri, sulle strade e all’ONU.
Pur nella sintesi inevitabile di una recensione di poche righe potete notare quanto approssimativa e fragile sia la storia di questo Black Panther. Un film che sembra interamente chiuso su se stesso, fatto da afroamericani, con afroamericani, per afroamericani.

La stessa caratterizzazione dei protagonisti è sconcertante. T’Challa è il supereroe più debole e inutile mai visto su uno schermo: quasi perde il primo duello, per poco non muore nel secondo con il cugino, la sua unica forza è nell’armatura di vibranium, che la sorella progetta per lui. Anche nel finale, ha bisogno dell’aiuto della tribù ribelle, per sconfiggere Erik Stevens. E, dopo averlo sconfitto, fa esattamente quello che il cugino avrebbe voluto fare: sconfessa il padre T’Chaka, abbandona segretezza e isolazionismo e mette il vibranium a disposizione del mondo.
Chadwick Boseman lo interpreta con una tale inutile gravitas, neanche fosse in un Macbeth shakespeariano al West End. Lupita Nyong’o, quasi sempre ripresa in primo piano, interpreta un ruolo femminile di pura funzione romantica, che sembra uscito dalla penna di qualche sceneggiatore degli anni ’50, altro che #timesup. Letitia Wright è la sorella di T’Challa, nel ruolo che, in tutti i film di Bond, è interpretato da Q, ovverosia il genio hi-tech chiuso in laboratorio. A Michael B. Jordan e Daniel Kaluuya, fresco di affrettata nomination all’Oscar, toccano i ruoli dei villain, tagliati con l’accetta.

Coogler, che si era distinto con l’essenziale Fruitvale Station, candidato all’Oscar, prima di passare a Creed con Stallone, si è trovato in un lampo a dirigere un fumettone pieno d’orgoglio black per la Marvel, senza accorgersi che il suo sguardo sull’Africa non è mai davvero progressista e che il suo revenge dream utopico di Wakanda, affoga nella sua goffa incompetenza, come regista d’azione e di masse.
Siamo di fronte, nè più, nè meno, all’ennesimo capitolo della soap Marvel: dopo il demenziale Thor: Ragnarok ecco il seriosissimo e finto-impegnato Black Panther. Il pendolo oscilla e con l’intelligenza di sempre, Kevin Feige è riuscito a dare al suo pubblico, ancora una volta, uno spettacolo del tutto innocuo, che non richiede alcun coinvolgimento intellettuale e che sfrutta alla perfezione lo zeitgeist del suo tempo, per incassare una valanga di dollari, con il solito sublime cinismo.
Chapeau!
In sala per la Disney.